Sassoon: i Rothschild d’Oriente – MN #338
In questo video, vedremo una delle principali famiglie che hanno dominato il mondo in modo occulto e con mezzi anche criminali. Il documentario sulle guerre dell’oppio è stato chiaramente realizzato con la sponsorizzazione del Partito Comunista Cinese e lo abbiamo presentato nella nostra serie sulla guerra dell’oppio. Il suo contenuto è valido, ma non completo. Infatti, con l’aiuto del nostro analista finanziario cinese Ken Cao, ricollochiamo la storia in una prospettiva più corretta. Ecco il suo contributo.
Un cervo vestito da cavallo
[Ken Cao]
Buongiorno amici. Lasciate che vi chieda una cosa. Se un tizio vi dicesse che la sua azienda di famiglia ha funzionato senza intoppi per 5.000 anni, attraverso guerre, invasioni, cambi di regime, intere popolazioni che morivano di fame, reset culturali totali e un vero e proprio genocidio, gli credereste? Non credo. Ma in qualche modo, quando il Partito Comunista Cinese dice che la Cina ha 5.000 anni di civiltà ininterrotta, milioni di persone annuiscono e dicono: “Wow, incredibile”. Bene, oggi sono qui per sfatare quel mito perché questa non è solo una cattiva interpretazione della storia. È una colossale bugia che viene usata per sostenere un regime che si poggia su una massa di rovine e sul cosplay. Mettiamo in chiaro una cosa. La civiltà è una cosa diversa dalla storia. Non c’è alcun dubbio, la terra che ora chiamiamo Cina ha 5.000 anni di storia. Ma che possiamo dire della civiltà? La parola significa qualcos’altro. Non si tratta di antiche teiere o di qualche polveroso treppiede di bronzo che avete visto in un museo. La civiltà riguarda i valori, le istituzioni razionali, la libertà intellettuale, un nucleo morale che sia funzionante.
Una civiltà tollera il dissenso. Protegge la verità. E quando quel nucleo muore, non avete più una civiltà anche se tutti gli edifici sono ancora in piedi, anche se avete ancora templi e cappelli cerimoniali. Avete una memoria, che tuttavia è priva di significato. E volete sapere quando questo cambiamento è successo in Cina? Tutto è iniziato con un cervo. C’è una vecchia storia della dinastia Qin, conosciuta in cinese con una frase proverbiale che significa indicare un cervo e chiamarlo cavallo. Un giorno, un funzionario assetato di potere di nome Zhao Gao portò un cervo dall’imperatore e gli disse: “Ecco un bel cavallo”.
Ora, alcuni ministri che erano presenti annuirono nervosamente. E dissero che quello era ovviamente un cavallo. Altri sbatterono le palpebre e dissero: “Aspettate un attimo gente, quello è un cervo, non un cavallo”. Indovinate cosa accadde a quelli che avevano detto la verità? Furono giustiziati. Da quel momento in poi, la realtà smise di avere importanza. Il potere decretò quella che era la nuova verità e tutti hanno imparato a mentire per sopravvivere. Non è stato un incidente di percorso. è stato un completo aggiornamento del software. La dinastia Qin non ha unificato la civiltà cinese, l’ha appiattita con uno schiacciasassi. Ora, veniamo alla parte che il Partito Comunista Cinese non vuole assolutamente che voi ricordiate. L’età d’oro della civiltà cinese è avvenuta quando la Cina non era nemmeno unificata. Avete capito giusto, il periodo delle Primavere e degli Autunni e degli Stati Combattenti, più di 2.000 anni fa, era disordinato, caotico e decisamente sanguinoso. Sette stati maggiori, dozzine di stati minori, nessuna autorità centrale, guerra senza sosta. Fondamentalmente Game of Thrones, edizione orientale.
Ma era un’epoca intellettualmente gloriosa, l’età d’oro delle idee. Quello fu il periodo in cui Confucio insegnò la virtù e l’armonia, Laozi scrisse e disse a tutti di rilassarsi e seguire il Tao. Mencio esplorò la natura umana. Mozi, Xunzi, Zhuangzi tutti dibattevano su ciò che rende una società giusta. C’erano scuole di pensiero in competizione, un dibattito aperto, un vero pluralismo. Era disordinato, era vibrante, era civilizzato. E poi arrivò la dinastia Qin che, per la prima volta, unificò l’intera Cina, e qual è stata la loro prima mossa?
Bruciare i libri, seppellire gli studiosi, mettere fuori legge ogni filosofia che non obbedisse all’imperatore. Il dibattito è stato sostituito dal dogma. La verità è stata sostituita con la paura. L’unità è arrivata a spese della civiltà. E per i successivi 2.000 anni, il copione non è cambiato nemmeno di una virgola. Ogni nuovo imperatore aveva la stessa ideologia, vale a dire obbedisci o muori. La gente ama romanticizzare la dinastia Tang come se fosse un’utopia avvolta nella seta e nella poesia. E, dobbiamo riconoscerlo, c’erano grandi poeti, il commercio era fiorente, una cultura in piena espansione, fino a quando ha smesso di funzionare, perché sapete cos’altro aveva la dinastia Tang? Intrighi di corte talmente disordinati da far apparire la successione al trono come una soap opera. I signori della guerra si spartivano l’impero come dei commensali che si spartiscano gli avanzi di un’anatra. E la ribellione di An Lushan fu una guerra civile così enorme che uccise 40 milioni di persone. Intere province furono cancellate dalla mappa.
Ma certo, potete anche definirla età dell’oro, ma non dovete grattare troppo la superficie altrimenti troverete una montagna di ossa. Ora, parliamo delle due dinastie che il Partito Comunista Cinese vuole farvi pensare siano state solo capitoli etnicamente diversi della gloriosa storia della Cina, vale a dire la dinastia Yuan e la dinastia Qing. Vi anticipo da subito il finale. Non erano affatto cinesi. Erano occupanti stranieri che governavano la Cina come se fosse un trofeo vinto durante una razzia. Cominciamo dai mongoli. Nel 1271, Kublai Khan, nientemeno che il nipote di Gengis Khan, si dichiarò imperatore della dinastia Yuan. Ma non è diventato cinese, ha invece reso la Cina mongola. I mongoli erano in cima alla graduatoria sociale. I cinesi Han erano in fondo. Il sistema legale era nettamente diviso in base alla razza. Non potevate portare armi, non potevate sposare un mongolo, non potevate nemmeno andare a cavallo a meno che non apparteneste all’élite più elevata. Questa non era inclusione. Questa era pura e semplice occupazione straniera. Adesso passiamo ai Manciù. Andiamo avanti veloce fino al 1644.
I Manciù invasero Pechino provenendo da nord-est. Lingua diversa, costumi diversi, visione del mondo diversa. Fecero radere la fronte ai cinesi Han e gli fecero portare una lunga treccia, un codino, in segno di sottomissione. Governavano attraverso la censura e la paura. Molte tradizioni e ideali cinesi furono calpestati nel fango. Ma in qualche modo ci viene ancora detto che la dinastia Qing è stata solo un altro capitolo della gloriosa civiltà cinese. Non è vero. È stato un governo di invasori stranieri che è durato per più di 200 anni. E proprio quando si pensava che la civiltà cinese potesse riprendersi, arriviamo al 1949. Entra in gioco il Partito Comunista Cinese. E qual è la loro prima mossa? Una piccola cosa chiamata Rivoluzione Culturale, che suona come un festival musicale, ma in realtà è stata un tracollo nazionale che è durato dal 1966 al 1976.
Templi di Confucio demoliti, monasteri buddisti distrutti, sacerdoti taoisti picchiati per le strade, testi antichi bruciati a vagonate, insegnanti e studiosi torturati o uccisi. E dovremmo credere che questo regime sia ora il guardiano di 5.000 anni di cultura? Neanche per sogno. Il partito non ha ereditato la civiltà cinese, l’ha macellata e poi ha reclamato il cadavere. Oggi sfilano in abiti cinesi tradizionali, costruiscono statue di Confucio, tengono cerimonie del tè e spalmano i valori tradizionali sulla propaganda di stato. Ma non fatevi ingannare. Il vero Confucio sarebbe stato epurato. Il vero Laozi sarebbe stato incarcerato. Il vero Mencio sarebbe stato cancellato con l’accusa di aver diffuso l’idealismo democratico occidentale. Questa non è tradizione.
È un cervo vestito da cavallo, proprio come lo aveva pianificato Zhao Gao. Allora perché continuare a propagandare questo mito? Perché è politicamente conveniente. Se convinci le persone che sei l’erede di 5.000 anni di grandezza, non hai bisogno di elezioni, consenso e nemmeno di competenza. Basta dire semplicemente: “Noi siamo la Cina, siamo grandi”. E la menzogna diventa legge. Ma lasciatemi dire chiaramente che il Partito Comunista Cinese non è la Cina e la Cina moderna non è neanche lontanamente… non è neanche lontanamente vicina al livello dell’antica civiltà. È una dittatura seduta su rovine rubate e libri bruciati.
La Cina ha 5.000 anni di storia, non c’è alcun dubbio, ma non ha assolutamente 5.000 anni di civiltà ininterrotta. La vera civiltà è finita molto tempo fa con i libri bruciati, i filosofi assassinati, gli imperatori stranieri e le purghe ideologiche. La civiltà riguarda la verità, l’etica, la libertà di pensiero. E quando uccidi quelle cose, non importa quanti anni abbia il tuo paese, non sei civilizzato. Quindi non lasciatevi ingannare dai templi, dall’incenso o dai costumi da drago.
A volte la menzogna più pericolosa è quella che indossa abiti di seta e cita Confucio, mentre, al tempo stesso, lo riscrive.
I veri padroni del traffico d’oppio in Cina
Dunque, vediamo che la Cina è sempre stata abitata da un popolo molto laborioso. La Cina è sempre stata abitata da un popolo molto laborioso, tuttavia per lungo tempo è stata soggetta a regimi dittatoriali. Molta della cultura cinese, come la religione buddhista, proviene dall’India e lo studio del ruolo dell’India nella guerra dell’oppio ci permette di avere una visione più ampia. Abbiamo visto, nelle serie sulle guerre dell’oppio, personaggi come i britannici William Jardine e James Matheson, gli americani Robert Bennet Forbes e Warren Delano, e i cinesi Howqua, tutti con un ruolo decisivo nella diffusione dell’oppio in Cina. Ma nel documentario manca forse il nome più importante. Per quale motivo? Vi presento quindi un nuovo documentario che credo troverete interessante. Eccolo.
[Narratore – Hidden Billionaire]
Prima che i grattacieli illuminassero lo skyline di Shanghai, prima che i moli di Mumbai scoppiassero di attività commerciali, c’era un nome sussurrato nei corridoi del potere da est a ovest: Sassoon. Una famiglia così ricca, così influente che persino i potenti Rothschild d’Europa dovevano tenerne conto. Costruirono sinagoghe scintillanti in Oriente, cenarono con gli aristocratici britannici in Occidente e spostarono milioni di persone attraverso gli oceani senza sollevare una spada. Il loro impero era costruito su seta, spezie e argento, ma anche su qualcosa di molto più distruttivo. Dietro le loro sontuose dimore e i raffinati ritratti di famiglia c’era una verità che in seguito avrebbe perseguitato le generazioni successive.
I Sassoon non si limitavano a commerciare merci. Trafficavano tossicodipendenza. La loro fortuna è stata costruita su un unico tipo di coltivazione, i papaveri, e la loro eredità è stata ricavata dalle rovine delle fumerie d’oppio in tutta l’Asia. Questo è Hidden Billionaire, e oggi scopriamo l’oscura storia dei cosiddetti Rothschild d’Oriente, una dinastia che ha contribuito a costruire il mondo moderno derubandolo silenziosamente. E per capire come ci sono riusciti, come una famiglia di rifugiati ebrei di Baghdad sia diventata burattinaia dell’economia asiatica, dobbiamo iniziare dall’inizio, il giorno in cui un uomo è fuggito dalle persecuzioni e ha messo piede sulle coste dell’India britannica.
David Sassoon non era un rifugiato qualunque. Nato a Baghdad nel 1792 da un’importante famiglia ebrea, visse una vita a cavallo tra due mondi. Suo padre, Sassoon Ben Saleh, era il capo tesoriere dei pascià dell’Impero Ottomano, un lavoro che diede a David un accesso precoce agli strumenti del denaro, dell’influenza politica e della diplomazia. Quel ruolo arrivò con immenso prestigio, ma anche con una pericolosa vicinanza alla politica ottomana, dove le alleanze erano fragili e la fiducia raramente durava più di qualche stagione. David crebbe a un bivio, circondato da testi sacri e rituali sinagogali a casa, e monete imperiali e documenti commerciali al lavoro.
La sua educazione includeva la Torah e il Talmud, ma anche l’arabo, il persiano, il turco e l’ebraico. Questa sua destrezza linguistica, assorbita con la stessa naturalezza con cui si respira l’aria, sarebbe diventata una delle sue più grandi armi negli affari. Poteva parlare con i religiosi musulmani, gli ufficiali britannici e i commercianti cinesi senza un traduttore. In un mondo coloniale diviso dalla lingua e dalla cultura, David era un ponte, e i ponti vengono pagati. Negli anni ’20 dell’Ottocento, la persecuzione degli ebrei di Baghdad si intensificò.
Il pascià, che un tempo si era fidato dei Sassoon, iniziò a prendere di mira proprio la comunità che lo aveva servito. Le sinagoghe furono perquisite. Le famiglie benestanti subirono l’estorsione del governo. Le crepe nella tolleranza ottomana divennero voragini. David aveva una scelta: restare e rischiare tutto, oppure fuggire verso l’ignoto. Scelse l’esilio, prima andando in Persia, e poi spostandosi più a est. Nel 1832 arrivò a Bombay, quella che oggi chiamiamo Mumbai. Era un rifugiato senza una posizione formale, ma con la mente che stava già calcolando come costruire il suo prossimo impero. Aveva portato con sé più che l’istinto per gli affari. La sua prima moglie, Hannah Joseph di Bassora, proveniva da un’altra ricca famiglia ebrea, e la loro unione creò legami sociali e commerciali in tutta la regione. Hannah gli diede quattro figli prima di morire prematuramente.
Ma fu il suo secondo matrimonio con Flora Haim che plasmò davvero la storia. Ebbero altri 10 figli, otto maschi e due femmine, ognuno dei quali David allevò con uno scopo ben preciso. Nel 1832 era arrivato a Bombay senza un soldo, ma determinato a ricostruirsi una vita. Quello che trovò non era solo un rifugio. Era un mondo sull’orlo della trasformazione, e tutta la sua ascesa iniziò, in effetti, a Bombay. David aprì un’attività nel commercio tessile, acquistando tessuti dall’India, vendendoli in Medio Oriente e reinvestendo i profitti per espandere la portata della sua attività. Ma questo non era un semplice caso di comprare a basso prezzo e vendere ad alto prezzo. David stava giocando un gioco di scacchi. Costruì magazzini vicino alle rotte di navigazione britanniche.
Fece generose donazioni a enti di beneficenza locali e, silenziosamente, agli amministratori coloniali. Finanziò scuole e ospedali e, allo stesso tempo, chiese tariffe preferenziali e scorte militari per le sue navi. La filantropia non era una distrazione dal business, anzi faceva parte integrante del business. Questa generosità strategica aiutò i Sassoon a ottenere licenze e protezione che altri commercianti potevano solo sognare. Mentre i concorrenti venivano tassati oppure sottoposti a ritardi arbitrari, le navi dei Sassoon passavano liberamente, spesso trasportando più di un semplice tessuto, perché alla fine degli anni ’30 dell’Ottocento, David aveva trovato qualcosa di ancora più redditizio del cotone: l’oppio.
A quel tempo, gli inglesi coltivavano papaveri in India, li trasformavano in mattoni d’oppio e li spedivano in Cina, dove milioni di persone ne stavano diventando dipendenti. Ma avevano bisogno di distributori, di persone che conoscessero il terreno locale e che non facessero domande. David Sassoon si fece avanti per soddisfare tale necessità. Acquistava l’oppio direttamente dalle fattorie gestite dagli inglesi. Poi, usando la sua rete di figli e alleati, creò catene di approvvigionamento in tutta l’India e in Cina. Il prodotto si spostava dai campi di papavero alle città portuali, poi sulle navi e nel cuore delle province più vulnerabili della dinastia Qing. Gli agricoltori indiani erano sempre più costretti a coltivare papaveri invece di cibo.
Alcuni protestarono, altri morirono di fame. Ma la domanda di oppio e i relativi profitti continuavano ad espandersi. I funzionari britannici chiudevano un occhio. Dopotutto, la loro economia era in piena espansione. Nel frattempo, le comunità cinesi venivano svuotate. La dipendenza era ovunque. Le famiglie vendevano i propri averi, a volte anche i loro figli, per permettersi un’altra dose. I leader locali imploravano aiuto, ma l’aiuto non arrivò mai. In mezzo a tutto questo, la ricchezza di David Sassoon esplose. I suoi figli gestivano diverse regioni, una a Shanghai, un’altra a Singapore, una terza a Hong Kong. Ognuno di loro si comportava come l’amministratore delegato di una filiale, riferendo al patriarca della famiglia che si trovava ancora a Bombay.
Costruirono scuole e sinagoghe in ogni città che toccarono, non solo per l’immagine, ma per rafforzare anche un senso di legittimità morale. Ai loro occhi, i membri della famiglia Sassoon non erano pirati o contrabbandieri. Erano individui che stavano edificando una nuova società. Eppure, dietro le mura di ogni sinagoga da loro finanziata, dietro le vetrate e i testi sacri c’erano libri mastri pieni di cifre che riportavano i volumi di oppio spedito e il relativo peso, con i profitti ricavati. Le preghiere del mattino erano seguite dai calcoli pomeridiani, la carità e il commercio si intrecciavano strettamente. Era un paradosso, ma funzionava.
La famiglia Sassoon non aveva bisogno di un esercito. Avevano a propria disposizione rotte di navigazione, monete d’argento e la benedizione della corona britannica. Ciò che rendeva i Sassoon diversi non era solo il fatto che erano intelligenti. È che erano perfettamente posizionati culturalmente, politicamente e geograficamente per sfruttare un mondo in transizione. In un momento in cui l’Asia veniva aperta dalle potenze europee, i Sassoon divennero il perfetto intermediario tra impero e opportunità. Parlavano le lingue. Conoscevano le usanze. Sapevano come navigare tra i bazar persiani, le sale riunioni britanniche e le città portuali cinesi. Per gli inglesi, erano soci affidabili e abbastanza familiari a cui affidare il proprio commercio.
Per la gente del posto, non erano abbastanza stranieri da essere odiati come i signori coloniali. Camminavano sul filo del rasoio e riscuotevano pedaggi da entrambe le parti. Al centro di tutto c’era il commercio dell’oppio. Negli anni ’40 dell’Ottocento, l’oppio non era più solo un prodotto. Era un sistema. La Gran Bretagna lo coltivava in India, lo vendeva in Cina e usava i profitti per acquistare tè, seta e porcellana. Questo triangolo commerciale alimentò l’economia britannica e i Sassoon ne divennero il nervo centrale. Non si limitavano a comprare e vendere. Controllavano l’intero sistema. Infatti, costruirono magazzini vicino ai forti militari. Organizzarono flotte che si muovevano come un orologio. E in ogni porto chiave, Bombay, Calcutta, Singapore, Hong Kong, Shanghai, installarono uno dei loro figli. Ogni figlio era più di un mercante.
Era un console, un negoziatore, un capo della logistica e talvolta anche una spia. Corrompevano i funzionari locali. Collaboravano con i comandanti britannici. Pagavano il pizzo ai pirati, qualunque fosse il costo. E gli inglesi adoravano questo modo di lavorare. Era l’efficienza del libero mercato con risultati coloniali. E quando la Cina cercò di resistere, l’impero reagì. Nel 1856 scoppiò la seconda guerra dell’oppio. La Cina aveva cercato di bloccare le importazioni di oppio. Gran Bretagna e Francia risposero con le navi da guerra. Le città cinesi furono bombardate, i palazzi vennero bruciati e, dopo che la Cina ebbe perso per una seconda volta, fu costretta ad aprire 11 nuovi porti per il commercio estero in base al trattato di resa. Fu uno dei capitoli più umilianti della storia cinese. Oggi è conosciuto come parte del Secolo dell’Umiliazione, un periodo in cui le potenze straniere si sono spartite l’economia cinese come se fossero al banco di un buffet.
I Sassoon aprirono case commerciali in tutti i porti principali. Firmarono accordi con gli amministratori coloniali per aprire i propri uffici all’interno di immobili di prima qualità che si trovavano sul lungomare. Le loro navi trasportavano oppio in andata e tessuti al ritorno, raddoppiando i loro profitti ad ogni viaggio. Offrivano prestiti ai mercanti locali, dopo di che si impadronivano dei loro beni quando i debitori non potevano pagare. Costruirono banche, investirono in banchine, si espansero acquistando cotonifici e immobili. Negli anni ’60 dell’Ottocento, i Sassoon non erano solo ricchi.
Erano essenziali per il dominio britannico in Asia. E con i soldi arrivò anche l’accesso sociale. Albert ed Elias Sassoon, i figli maggiori di David, trasformarono l’azienda in un impero multinazionale su larga scala. Ma trasformano anche l’immagine della famiglia da quella di commercianti orientali a membri delle élite occidentali. Albert, in particolare, aveva progetti a lungo termine. Si trasferì a Londra, acquistò una proprietà nel quartiere esclusivo di Mayfair, e iniziò a intrattenere i nobili britannici in cene kosher che sembravano abbastanza esotiche da incuriosire, ma abbastanza rispettabili da essere accettate.
Finanziò ospedali, donò alle università e costruì ponti culturali che fecero sembrare la famiglia più aristocratica che mercantile. Alla fine, la regina Vittoria lo nominò cavaliere. Divenne Sir Albert Abdullah David Sassoon, Baronetto di Bombay, un titolo che rese chiaro che i Sassoon erano arrivati nell’alta società. Ma non tutti in famiglia seguirono la via della diplomazia e della discrezione. Reuben Sassoon, cugino minore di Albert, si trovò nel bel mezzo di uno scandalo che scosse l’alta società britannica. Tutto iniziò nel 1890, con un gioco di carte. Lo scandalo del Royal Baccarat, come sarebbe stato chiamato in seguito, coinvolse il futuro re Edoardo VII, allora principe di Galles, e una piccola cerchia di aristocratici. Alloggiavano in una tenuta di campagna, giocando d’azzardo al baccarat con puntate molto alte, un gioco illegale all’epoca. Reuben Sassoon era presente.
Quando uno degli ospiti fu accusato di barare, il principe lo difese. Reuben, intrappolato tra lealtà e rischio legale, si ritrovò invischiato in un dramma giudiziario che trascinò la famiglia reale e il nome dei Sassoon sui tabloid. Lo scandalo mise in imbarazzo la monarchia e attirò un’attenzione indesiderata sull’ascesa fulminea dei Sassoon. I sussurri cominciarono a circolare nei salotti. La gente si chiedeva da dove venissero davvero i soldi di questa famiglia. Ma in vero stile dinastico, la famiglia disinnescò lo scandalo. Fece donazioni alle cause giuste, e si profuse in scuse verso chi di dovere. Reuben si ritirò silenziosamente dalla vita pubblica, mentre Albert raddoppiò la propria rispettabilità, inserendosi ulteriormente nelle istituzioni britanniche.
E mentre lo scandalo svaniva, l’impero dei Sassoon continuava a crescere. La famiglia si espanse nel petrolio, nell’acciaio e nel trasporto marittimo. Costruì fabbriche tessili in India e portafogli immobiliari a Hong Kong. La loro fortuna non fu solo quella di sopravvivere allo scrutinio pubblico, ma di prosperare grazie al fatto di mantenere del tutto invisibili le parti più oscure della loro attività. Gli inglesi li vedevano come costruttori di imperi. Le élite asiatiche li vedevano come abili outsider. Pochi videro la sofferenza che giaceva sotto i numeri scintillanti dei loro bilanci, anche se quella sofferenza era assolutamente reale. Intere regioni dell’India erano bloccate nella coltivazione del papavero, le famiglie indiane non erano in grado di coltivare il proprio cibo perché l’uso della terra era controllato dalle quote commerciali coloniali. Le città cinesi erano piene di tossicodipendenti.
Gli operai lavoravano, senza alcuna protezione, seguendo orari brutali per le fabbriche di proprietà dei Sassoon. L’impero si era espanso ben oltre l’oppio, ma l’oppio aveva costruito le sue fondamenta, e la successiva generazione dei Sassoon avrebbe dovuto affrontare una questione che i loro padri avevano evitato: vale a dire come preservare la propria eredità quando il mondo inizia a chiedersi da dove provenga veramente la propria ricchezza. Alla fine del secolo, il nome Sassoon era diventato un simbolo di ricchezza, eleganza e influenza, almeno in superficie.
Organizzavano serate di gala all’interno di sontuose case londinesi. Possedevano banche e ferrovie. Costruivano biblioteche a Bombay e cattedrali del commercio a Shanghai. Ma nonostante tutto il loro successo esteriore, la dinastia stava entrando in una nuova fase, una in cui l’immagine contava quasi quanto il denaro. L’impero era stato costruito, ma ora dovevano difenderlo. E tale difesa arrivò sotto forma di arte, carità e influenza, e nessuno maneggiò tali strumenti più abilmente di Rachel Beer. Rachel nacque nel 1858 nel ramo ebraico di Baghdad della famiglia Sassoon, ma non era come gli uomini della sua famiglia che gestivano case commerciali o intrattenevano rapporti con i funzionari coloniali. Rachel era più acuta, più audace, non interessata solo a contare i soldi. Voleva dare forma alla narrazione, e lo fece.
Nel 1891 prese le redini di The Observer, uno dei più antichi giornali della Gran Bretagna. Due anni dopo, acquistò anche il Sunday Times. Questo non era un ruolo simbolico. Rachel era la direttrice del giornale, la prima donna a detenere un tale potere nel giornalismo britannico. In un’epoca in cui la maggior parte delle donne non poteva votare e nemmeno frequentare l’università, Rachel Beer influenzava ciò che la Gran Bretagna leggeva ogni fine settimana. Tuttavia, la sua ascesa ebbe un costo. Il suo matrimonio con Frederick Beer, un cristiano, creò una spaccatura all’interno della famiglia Sassoon. Lo consideravano un tradimento della fede e della tradizione. Rachel, imperterrita, costruì un impero mediatico alle sue condizioni, ma il suo momento più grande sarebbe arrivato nella tempesta scatenata dall’Affare Dreyfus. Nel 1894, Alfred Dreyfus, un ufficiale ebreo dell’esercito francese, fu falsamente accusato di tradimento.
Il caso scatenò sommosse antisemite e divise l’Europa. La maggior parte dei giornali soffiava sul fuoco per incitare la folla. Ma Rachel prese una posizione opposta. Indagò lei stessa sul caso e, con una mossa a sorpresa, pubblicò un’intervista in cui il vero colpevole, il conte Esterhazy, confessava. Quella singola intervista contribuì a spostare l’opinione pubblica e, in ultima analisi, contribuì all’esonero di Dreyfus. Era stata una mossa audace, pericolosa e trasformativa, ma benché Rachel avesse usato il suo potere per la giustizia, lei, come il resto della famiglia Sassoon, rimase per lo più in silenzio su come era stata costruita la loro fortuna. Non ci furono editoriali sui contadini indiani costretti a coltivare papaveri invece del grano, non ci furono articoli del Sunday Times sui tassi di dipendenza dall’oppio in Cina o sulla corruzione coloniale.
L’eredità dei Sassoon veniva ripulita, ma non cancellata. Si trattava di un’operazione di modifica dell’immagine. I loro anni dell’oppio sono stati silenziosamente spazzati via dalle note a piè di pagina, mentre la loro filantropia è stata spinta al centro della scena. In India hanno costruito scuole e ospedali. A Londra hanno finanziato biblioteche e musei. A Shanghai hanno costruito alberghi e sinagoghe. Per il pubblico, non erano più mercanti. Erano modernizzatori, costruttori di imperi, mecenati della cultura. Ma non erano solo i soldi ad essere riciclati, erano loro stessi. La famiglia stava cambiando, non solo in ciò che possedeva, ma anche nella propria identità. Erano ebrei di Baghdad che si erano trasformati in aristocratici britannici. Servivano ancora cibo kosher, ma su porcellane pregiate e sotto lampadari importati da Parigi.
Frequentavano ancora la sinagoga, ma ora lo facevano con i cavalierati e i baronetti. Per molti nell’alta società, i Sassoon erano affascinanti, una famiglia che sembrava fluttuare tra i mondi. Erano ebrei, ma non troppo. Erano orientali, ma anche completamente occidentali. Insider e outsider allo stesso tempo. Ma con quella dualità è arrivata la tensione. Alcuni rami della famiglia si aggrapparono alle radici di Baghdad, preservando i testi ebraici, sostenendo l’educazione ebraica e mantenendo forti tradizioni religiose. Altri si abbandonarono all’assimilazione, sposandosi con l’aristocrazia britannica, anglicizzando i loro nomi e ritirandosi dalle origini della famiglia. I sussurri sulla provenienza dei soldi non sono mai scomparsi del tutto.
Lo scandalo del Royal Baccarat aveva peggiorato le cose, e, a porte chiuse, i membri più giovani della dinastia cominciavano a porre domande scomode, domande sulla moralità, sulla storia, sull’eredità della loro famiglia. Una di quelle voci era quella di Siegfried Sassoon, un lontano parente che sarebbe poi diventato uno dei poeti più famosi della Prima Guerra Mondiale. Siegfried combatté in trincea, vide morire gli amici e tornò a casa furioso per le menzogne che sostenevano la guerra e l’impero. Non parlava molto dell’azienda di famiglia, ma nei suoi scritti c’era sempre una tensione, la sensazione che l’onore e la sofferenza significassero più dello status sociale o della ricchezza. Nel frattempo, quando la Gran Bretagna e la Cina negoziarono un accordo nel 1907 per ridurre gradualmente il commercio dell’oppio, i Sassoon cambiarono di nuovo.
Cominciarono a disinvestire dai narcotici, riversando i loro soldi in industrie più rispettabili, nel settore immobiliare, bancario, manifatturiero. Ma ormai il danno era stato fatto. Intere economie erano state rimodellate, e quando il XX secolo prese vita con rivoluzioni, guerre e decolonizzazione, i Sassoon si trovarono di fronte a una nuova sfida, la sopravvivenza in un mondo che non potevano più controllare.
Negli anni ’20, la famiglia Sassoon non era più solo ricca. Erano reliquie di un’epoca che cominciava a crollare sotto le sue stesse contraddizioni. Il mondo che avevano contribuito a costruire, dove il commercio era controllato da una manciata di famiglie e le colonie si inchinavano ai padroni stranieri, stava cambiando rapidamente. I movimenti indipendentisti si stavano diffondendo. I lavoratori si stavano organizzando e, in tutta l’Asia, i motori dell’impero, un tempo invisibili, venivano trascinati alla luce. Ma anche se la marea era cambiata, un Sassoon non era pronto a rinunciare al centro della scena. Il suo nome era Sir Victor Sassoon.
Era tutto ciò che le generazioni precedenti non erano state, teatrale, estroverso e affamato di visibilità. Voleva trasformarsi, e il suo palcoscenico per questa reinvenzione sarebbe stata una città che, come i Sassoon, viveva a cavallo tra mondi diversi, vale a dire Shanghai. Negli anni ’20, Shanghai non era solo una città portuale. Era un parco giochi per le élite coloniali, un crogiolo di banchieri europei, gangster americani, magnati cinesi e tutti gli altri personaggi che costellavano quel mondo. E Victor era determinato a farlo suo. Riversò quindi la sua fortuna nel settore immobiliare, bancario, alberghiero e cinematografico. Ma il suo gioiello della corona fu un edificio che ancora oggi definisce lo skyline di Shanghai, il Cathay Hotel, ora noto come Peace Hotel.
Alto dieci piani, vestito in stile art déco, sormontato da un caratteristico tetto piramidale verde, il Cathay era un capolavoro. Sale di marmo, servizi d’argento, passaggi segreti e sale da ballo che riecheggiavano di jazz e profumavano di champagne. Dal suo attico, Victor poteva ammirare il Bund, il famoso lungo fiume di Shangai, e immaginarsi non solo come un uomo d’affari, ma come un vero e proprio marchio personale. E l’idea funzionò. Organizzava feste per diplomatici, per star del cinema e per membri della nobiltà reale. La sua foto appariva negli articoli di costume sull’alta società. Divenne una sorta di mito, l’affascinante baronetto di Bombay che rifece Shanghai a sua immagine. Victor sapeva che il mondo si stava rivoltando contro tutto ciò su cui era stato costruito l’impero dei Sassoon. L’era dello sfruttamento silenzioso era finita. In India, i lavoratori delle fabbriche tessili di proprietà dei Sassoon si univano ai movimenti sindacali. Leader nazionalisti come Gandhi e Nehru stavano denunciando i profittatori coloniali, chiedendo giustizia per generazioni di servitù economica.
Le famiglie che erano state costrette a coltivare oppio invece di cibo, ora opponevano resistenza e si organizzavano. In Cina, le ferite delle guerre dell’oppio non erano mai completamente guarite. Il cosiddetto Secolo dell’Umiliazione era ancora vivido nella memoria. E sia i nazionalisti che i comunisti erano d’accordo su una cosa, il controllo straniero doveva finire. I Sassoon, un tempo protetti dalle cannoniere britanniche, erano ora solo un altro simbolo dell’avidità imperiale. E poi arrivò il crollo. Nel 1937, il Giappone invase la Cina, scatenando una guerra su vasta scala. Le bombe caddero su Shanghai. L’Insediamento Internazionale, la zona in cui gli stranieri come Victor avevano vissuto al sicuro, non era più sicuro. Le rotte commerciali erano collassate. Le fortune economiche furono congelate. Il caos era tornato.
Victor, percependo la tempesta prima che colpisse, fuggì da Shanghai nel 1941, pochi mesi prima che le forze giapponesi occupassero la città. Si trasferì di nuovo in India, poi alle Bahamas. Il Cathay Hotel, un tempo simbolo della modernità dei Sassoon, non gli apparteneva più. L’impero era passato di mano. Per quasi un secolo, i Sassoon avevano superato in astuzia imperi, crisi e rivoluzioni cambiando strategia, adattandosi, e reinventandosi. Ma ora il mondo si era messo al passo. Il colonialismo stava crollando. L’ordine globale che aveva protetto la loro ricchezza veniva fatto a pezzi. Dopo la Seconda guerra mondiale, l’Asia non tornò alla normalità.
Si ridefinì. L’India ottenne l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1947 e, poco dopo, molte famiglie ebree, tra cui i Sassoon, iniziarono a lasciare Bombay. Le loro sontuose case divennero reliquie. Le loro fabbriche furono nazionalizzate o vendute. Il loro vecchio status di insider semi-nativi con potere coloniale, non era più sostenibile né praticabile. La Cina, dopo anni di guerra civile, cadde nelle mani dei comunisti nel 1949. L’impresa privata fu messa fuori legge. Gli uffici, i magazzini e le proprietà immobiliari dei Sassoon furono sequestrati. La fortuna che un tempo era fluita dall’oppio e dai tessuti svanì nel giro di pochi mesi. Nel 1950, l’impero dei Sassoon, almeno quello che David aveva costruito e Victor aveva reso affascinante, non era più una dinastia vivente. Era un fantasma. Ciò che rimaneva era l’architettura, l’eredità e la contraddizione.
Il Cathay Hotel si trova ancora sul Bund, oggi è un punto di riferimento di lusso per i turisti. I Sassoon Docks di Mumbai brulicano ancora di attività, ma non fanno più transitare l’oppio, bensì il pesce. La David Sassoon Library, aperta nel 1847, serve ancora studenti e studiosi, alcuni dei quali ora conducono ricerche sulla famiglia che l’ha costruita. Ma i giorni del controllo erano finiti. Le generazioni successive della famiglia si ritirarono in ruoli più tranquilli: diplomatici, filantropici, accademici. Non hanno più plasmato il destino dell’Asia. Si limitavano a osservarlo. Eppure, una domanda rimaneva: come si racconta la storia di una famiglia che ha donato biblioteche a Bombay e la dipendenza dall’oppio alla Cina, che ha preservato l’eredità ebraica e che ha tratto profitto dalla miseria coloniale, che ha costruito un impero globale solo per vederlo dissolversi mentre veniva travolto dalla storia. Questo è ciò che esploreremo nel nostro capitolo finale, dove l’eredità dei Sassoon non è più solo la ricchezza, ma la conversazione su cosa significhi costruire un impero e quanto costi mantenerne uno.
Negli anni ’60, gli ultimi Sassoon che avevano plasmato il vecchio mondo se ne erano andati. Victor Sassoon, l’esuberante baronetto che un tempo governava lo skyline di Shanghai, morì nel 1961, da solo alle Bahamas, lontano dall’impero che aveva cercato di reinventare. I porti non appartenevano più alla famiglia. I loro mercati erano chiusi. L’impero era diventato solo un ricordo. Ma i ricordi non svaniscono così facilmente. A Mumbai, i Sassoon Docks, costruiti nel 1875, rimangono uno dei mercati del pesce più frequentati della città, con oltre 150.000 persone che transitano regolarmente.
La David Sassoon Library, ancora in piedi con i suoi archi gotici, ospita ora gli studenti che fanno ricerche sull’uomo i cui soldi l’hanno costruita. Il suo nome è scolpito nella pietra, ma i lettori di oggi sfogliano quelle pagine con occhi nuovi, perché ora la gente si chiede: “Da dove vengono quei soldi?” Per decenni, la narrazione è stata quella della filantropia, dell’istruzione, del progresso. Ma quando gli studiosi iniziarono a riesaminare le radici della ricchezza coloniale, i Sassoon tornarono, non tanto come figure dimenticate, ma come casi di studio.
Per molti versi, sono stati l’esempio perfetto: una minoranza perseguitata che è diventata intermediaria del potere, tradizionalisti religiosi che hanno finanziato il commercio globale, costruttori di ospedali e scuole i cui profitti provenivano dalla dipendenza dall’oppio e dallo sfruttamento dei lavoratori nelle colonie. Non si trattava di una semplice storia di una famiglia che partendo dalla grande povertà conquista un’enorme ricchezza. Era un vero paradosso. Nel Ventunesimo secolo, questo paradosso divenne sempre più visibile. Università, musei e istituzioni pubbliche in tutto il Regno Unito e in India hanno iniziato a studiare i propri legami con le fortune dell’era coloniale. Alcuni hanno aggiunto targhe che riconoscono la fonte delle prime donazioni. Altri hanno lanciato intere iniziative di ricerca per studiare come famiglie come i Sassoon abbiano tratto profitto dall’impero.
Una di queste iniziative ha rivelato quanto fosse stata centrale questa famiglia, non solo per il commercio dell’oppio, ma per il modo in cui il capitalismo globale si era espanso in Asia.
Un modello che si sarebbe ripetuto in Europa
Come vediamo, il commercio dell’oppio non era il frutto unicamente dell’attività di alcuni mercanti criminali o delle mire espansionistiche dell’impero britannico. Sicuramente, sia l’impero britannico che diversi mercanti criminali hanno avuto un ruolo determinante. C’era però un ruolo centrale svolto da alcune famiglie di mercanti e banchieri che ambivano a governare il mondo. Il modello di abbinare filantropia, finanza e commercio monopolistico tradizionale al commercio di droga o ad altre attività criminali è stato esportato ovunque dopo l’esperimento cinese. I criminali si sentono le persone più oneste del mondo, come abbiamo visto anche nei video precedenti, e si circondano di attività apparentemente filantropiche per mascherare le proprie attività reali.
Queste attività, quelle reali, combinano, come abbiamo visto, droga, gioco d’azzardo, influenza politica, controllo dei mezzi di stampa, corruzione e femminismo. Su questo magari faremo un approfondimento futuro. Quello che notiamo è che, oltre al danno enorme prodotto sulla Cina, il commercio europeo ha avuto un impatto strutturale anche sull’India. Infatti, durante il dominio britannico, soprattutto tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XX secolo, milioni di contadini indiani furono costretti a coltivare il papavero da oppio in base a rigidi contratti.
Ciò ha portato all’eliminazione di coltivazioni alimentari come il miglio, il riso e i legumi, mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare locale. Non potevano coltivare il proprio cibo, ma erano costretti a coltivare l’oppio. La Compagnia britannica dell’India orientale imponeva infatti quote non negoziabili, spesso sostenute dalla polizia e dalle trappole del debito. Durante le annate di siccità, con conseguente carenza di raccolti, la mancanza di riserve alimentari causava carestie diffuse e, sebbene la coltivazione dell’oppio non fosse l’unica causa delle carestie, le rendeva sicuramente più gravi.
La carestia del Bengala del 1943, che si stima abbia ucciso tra i 2 e i 3 milioni di persone, fu infatti aggravata dall’agricoltura orientata alle esportazioni dell’oppio e dall’abbandono delle coltivazioni alimentari. La gente non aveva di che mangiare perché coltivava l’oppio e non poteva mangiarlo. Le precedenti carestie del Bihar, del Bengala e dell’Orissa, sempre verificatesi nel XIX secolo, furono intensificate dalla coltivazione dell’oppio e i documenti coloniali ne fanno menzione quando parlano delle morti causate da queste carestie, spesso attribuite a cause naturali come la siccità, piuttosto che ad altri fattori, mascherando tuttavia la violenza economica della monocultura forzata.
Storici moderni come, per esempio, Rolf Bauer sostengono che la coltivazione dell’oppio fu una perdita netta per la maggior parte dei contadini, intrappolati in cicli di debiti e malnutrizione. Quindi, il commercio dell’oppio e l’impero britannico non erano solo un’impresa commerciale, ma uno sfruttamento sistemico che dava priorità alle entrate imperiali rispetto alla vita umana. Inoltre, vediamo che Sassoon aveva replicato in Oriente il modello già adottato dai Rothschild in Occidente, distribuendo i propri figli in posizioni chiave, il che non fu una coincidenza, come vedremo nel prossimo video, in cui ci sarà un collegamento diretto tra le due famiglie.
Intanto, in chiusura, vi ricordo la famosa frase di Karl Marx: “La religione è l’oppio dei popoli”, tratta da un suo scritto del 1844 intitolato “Per la critica della filosofia del diritto di Hegel”. Il passaggio completo e più articolato è il seguente: “La religione è il sospiro della creatura oppressa, il cuore di un mondo senza cuore, così come lo è lo spirito di condizioni sociali prive di spirito: è l’oppio del popolo”. Quindi, gente, meditate e ci rivediamo al prossimo video.
Roberto Mazzoni
Commenti:
Donate
Possiamo fare informazione indipendente grazie al tuo sostegno. Se trovi utile il nostro lavoro, contribuisci a mantenerlo costante
Video collegati
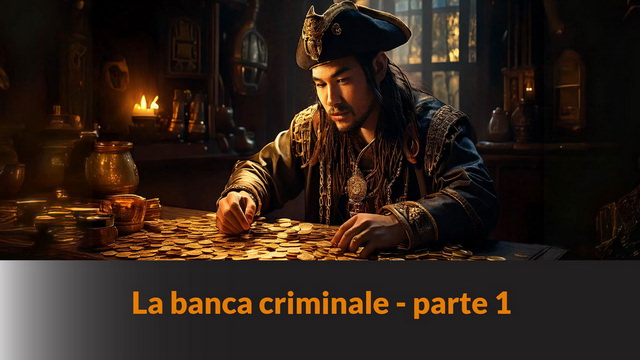
La banca criminale - parte 1 - MN #314

Le guerre dell’oppio – parte 1 – gemellaggio sino-spagnolo MN #313

